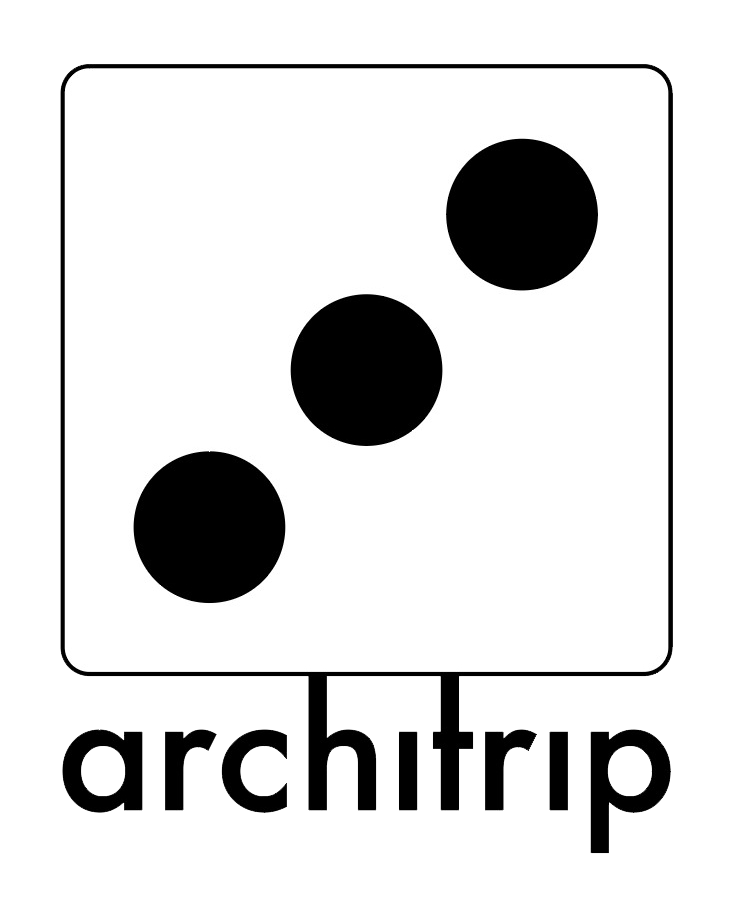In questo numero abbiamo deciso di concentrarci sulla figura dell’architetto Angelo Masieri, in occasione del centenario della sua nascita. Un architetto che nella sua brevissima carriera è riuscito a realizzare delle opere significative e sorprendenti. Ne abbiamo parlato con l’architetto Massimo Bortolotti autore, alcuni anni fa, di uno studio su questo importante collega.
Angelo Masieri è divenuto ormai una figura mitologica nell’ambito dell’architettura udinese, complice la sua prematura scomparsa puoi riassumerci brevemente le tappe del suo percorso?
La vicenda di Masieri si consuma in un ristretto arco di tempo: dal febbraio 1946, quando Angelo incomincia la professione, al giugno 1952 quando perde tragicamente la vita in un incidente automobilistico negli USA, ove si era recato per commissionare a F.L. Wright il progetto della sua casa a Venezia. Masieri proviene da una agiata famiglia. Il padre Paolo è ingegnere e titolare di un’impresa di costruzioni che era stata molto attiva negli anni trenta. Dopo gli studi al Liceo classico Stellini a Udine, Masieri si iscrive al Regio Istituto Superiore di Architettura di Venezia nell’anno accademico 1941-1942. Anni evidentemente difficili a causa della guerra. L’Istituto veneziano era retto allora dall’architetto Guido Cirilli che alla fine degli anni trenta aveva avviato un rinnovamento del corpo docente con l’ingresso ad esempio di Giuseppe Samonà, cui viene affidato il corso di Disegno architettonico e rilievo dei monumenti, e di Carlo Minelli per Scienza delle costruzioni. Masieri segue il corso di Samonà, ove esercitazioni grafiche si affiancavano al rilievo dal vero così da consentire agli studenti di comprendere meglio il rapporto fra l’edificio e il contesto urbano. Masieri frequenta anche il corso di Carlo Scarpa, docente di Disegno dal vero. Tra l’allievo e il docente nasce un rapporto di reciproca stima e di frequentazione anche fuori dalle aule di studio. Quando Masieri è al terzo anno di corso, nel novembre 1943, è proprio Samonà a sostituire Cirilli alla guida dell’Istituto. La formazione di Masieri si completa il quinto anno con il corso di Composizione architettonica tenuto dello stesso Samonà. Nel corso gli studenti dovevano progettare un organismo edilizio dopo aver esaminato vari aspetti: urbanistici, di distribuzione interna, gli elementi tecnologici e quelli costruttivi per “soddisfare le necessità spirituali e materiali dell’uomo” come si legge nel programma del corso.


Carlo Scarpa e Giuseppe Samonà sono quindi i principali riferimenti per la formazione del giovane architetto udinese che, dopo la laurea, chiede la collaborazione professionale di Carlo Scarpa per alcuni dei suoi primi lavori. Una missiva di Masieri a Carlo Scarpa, datata 19 gennaio 1948, testimonia la nascita della collaborazione professionale. “Egregio professore, alcune settimane fa mio padre ed io abbiamo ricevuto l’incarico dalla Banca Cattolica del Veneto di studiare un progetto per la nuova sede di Tarvisio. Avrei piacere di poter fare questo lavoro con lei”. Sono gli anni in cui Scarpa è infatuato dell’architettura organica di F.L. Wright e Masieri, dal 1947 fa parte, insieme a Samonà, Trincanato e Gellner, del consiglio direttivo dell’APAO (Associazione per l’architettura organica) del Veneto.
Vale la pena ricordare che solo due anni prima Bruno Zevi aveva dato alle stampe Verso un’architettura organica che diffondeva in Italia la conoscenza di F. L. Wright. L’adesione alla sezione veneta dell’APAO testimonia anche come la scuola di Venezia nell’immediato dopoguerra sia un terreno fertile per il recepimento dell’architettura organica e, più in generale, dei maestri del Movimento Moderno. I dibattiti e le conferenze che l’associazione promuove, come quella tenuta da Scarpa nel 1948 sull’architettura Liberty alla quale sicuramente Masieri assiste, permettono al giovane architetto l’acquisizione di nuovi spunti di riflessione. Sempre nel 1948 sono Samonà e Scarpa che invitano a Venezia Richard Neutra il quale presenta i suoi ultimi lavori realizzati a Los Angeles. Anche in questo caso è possibile ipotizzare la presenza di Masieri vista la citazione che egli fa di una soluzione adottata da Neutra in una lettera a Scarpa durante la progettazione della casa Giacomuzzi a Udine. Bisogna infine ricordare quale era il conteso in cui Masieri ha operato.
A Udine la ricostruzione postbellica e la crescita urbana traevano spunto dal piano regolatore di Cesare Pascoletti e Arnaldo Foschini nonché dell’ingegnere Paolo Bertagnollo. Il piano era stato approvato nel 1939, ma solo dieci anni dopo non trovava la sua applicabilità per le mutate condizioni in cui versava l’edilizia alla luce dei bombardamenti e dei differenti interessi speculativi. Si discuteva sulla sistemazione dell’area ex Moro e si preparavano, dopo gli interventi in piazza Duomo dell’edificio INAIL di Pascoletti, ulteriori alterazioni del tessuto storico edilizio.
Poche, come noto, le sue opere: a Udine la casa Giacomuzzi, l’edificio in viale Duodo, la palazzina per uffici in via Uccellis oltre la sistemazione del proprio studio nel Palazzo Porta ove i Masieri risiedevano, la tomba Veritti e villa Romanelli, lasciata alle opere di fondazione e ultimata da Carlo Scarpa e Bruno Morassutti nel rispetto del progetto del giovane collega scomparso. A Cervignano troviamo poi la villa Bortolotto e un piccolo edificio a Codroipo.

Una vita fatta di relazioni e di curiosità quale motore che ha permesso di ottenere risultati notevoli raccontaci meglio le dinamiche di quegli anni tra gli architetti.
Certamente le relazioni e le conoscenze del padre consentono ad Angelo di ottenere i primi incarichi professionali (l’incarico per la banca a Tarvisio, ad esempio, era affidato anche al padre, e l’amicizia di Paolo Masieri con l’ingegnere Giacomuzzi favorisce gli incarichi per la Società Friulana di Elettricità).
La frequentazione con Scarpa permette a Masieri di conoscere personalmente figure importanti come Carlo Ludovico Ragghianti e Bruno Zevi, che era arrivato allo IUAV dopo la laurea di Masieri. Ricordo che Masieri può seguire Wright, in un gruppo molto ristretto, durante la visita a Venezia, come testimoniato ad esempio dalla fotografia scattata nel laboratorio della vetreria Venini. Qui possiamo vedere F.L. Wright mentre assiste al lavoro dei maestri vetrai circondato, fra gli altri, da Scarpa, Zevi, De Luigi ed è presente anche Angelo con la giovane moglie Savina.
Pochi giorni dopo, Angelo e Savina, insieme al padre, sono a Firenze all’inaugurazione della mostra su Wright a Palazzo Strozzi. La disponibilità economica consente questo come viaggi ad esempio a Marsiglia per visitare il cantiere lecorbuseriano de l’unitè d’Habitation o il viaggio negli USA che gli sarà fatale. Masieri si mostra quindi curioso a 360 gradi rispetto alle novità dell’architettura. Cosi ad esempio ordina a una libreria di Londra testi sui giardini giapponesi e sull’architettura giapponese. Uno di questi libri il testo di J. Harada The Gardens of Japan, lo regala a Carlo Scarpa che lo conserverà gelosamente appuntandoci la scritta “Dono della Savina e di Angelo. Caro Angelo!”

Raccontaci meglio le dinamiche di quegli anni tra gli architetti.
Per quanto attiene alle dinamiche tra gli architetti, partiamo dall’Albo professionale dove, alla fine degli anni quaranta, vediamo numeri molto diversi da quelli attuali: gli iscritti sono poche decine e in piena attività incontriamo architetti come Ermes Midena, Pietro Zanini, Provino Valle che negli anni trenta avevano applicato il linguaggio del razionalismo. A questi si affiancano le giovani leve come Gianni Avon, Marcello D’Olivo, Gino Valle, tutti formati a Venezia e attivi professionalmente dal 1946-47. A questi vanno aggiunti Carlo Mangani e Paolo Pascolo formati rispettivamente a Milano e Roma.
È noto il giudizio espresso da Ernesto N. Rogers su Masieri e sui “giovani colleghi della sua generazione: tutti insieme parevano dare spallate alle mura di quella città dove, dal principio del secolo, l’architettura del D’Aronco aveva già rotto una breccia agli argini provinciali”. Roger formulò quel giudizio dopo la sua venuta ad Udine in occasione di una conferenza all’Università Popolare nel dicembre del 1950. Il che testimonia della vivacità del clima culturale cittadino all’epoca. Solo due anni prima, nel 1948, nelle sale della Loggia del Lionello si era svolta la Mostra di Architettura Moderna organizzata dalla Società di Architettura di Torino che presentava le fotografie di opere, fra gli altri, di F.L. Wright e di Alvar Aalto. Da notare inoltre che tra i giovani architetti vi era spesso collaborazione (ad esempio incarichi condivisi tra Avon e D’Olivo nel 1947) o comunque l’abitudine a mostrare ai colleghi i propri lavori.

Ricordo che Cesare Bortolotto, committente di Masieri per la villa a Cervignano, mi parlò di lunghe visite al cantiere fatte da Gino Valle oltre a Carlo Scarpa e di momenti conviviali in cui i tre architetti discutevano delle soluzioni progettuali adottate. Certo nel caso di Masieri la collaborazione con Scarpa risulta fondamentale.Se infatti può risultare facile comprendere i motivi che sottendono la richiesta di “aiuto” dell’alunno al professore, meno evidenti appaiono le ragioni che spinsero Scarpa ad accettare, con entusiasmo, le proposte di collaborazione in alcuni lavori (Banca a Tarvisio, casa Giacomuzzi, villa Bortolotto, tomba Veritti). È necessario ricordare che alla fine degli anni quaranta e nei primissimi anni cinquanta le opere realizzate da Scarpa non erano numerose e soprattutto si riferivano per lo più ad allestimenti di mostre, sistemazioni di appartamenti o tombe. La collaborazione con Masieri offre quindi a Scarpa la possibilità di seguire nuovi cantieri. Per entrambi si tratta di fare esperienza attraverso i cantieri e di cercare di mettere in pratica i modelli wrightiani, a cui allora entrambi fanno riferimento, applicandoli ai casi concreti delle commesse procurate dalle conoscenze di Paolo Masieri.
Il ritrovamento che ho fatto alcuni anni fa di un mannello di lettere di Masieri a Scarpa scritte durante la progettazione della Banca Cattolica a Tarvisio consentono di ipotizzare un metodo e comunque certificano uno scambio reciproco dove indubbiamente il maestro interveniva, sosteneva, proponeva, ma senza mai togliere all’allievo. Vi è ragione di pensare che questo metodo fatto di singole proposte, confronti e discussioni ma anche di lavoro fatto fianco a fianco sia a Venezia che a Udine sia stato tale anche per i successivi incarichi in cui Masieri coinvolge Scarpa.
Da notare che i riferimenti a Wright sono molto meno evidenti per le opere in cui Masieri non coinvolge Scarpa (edificio Rizzi in Viale Duodo, Edificio SFE).
Un accenno infine al tipo di committenza per la quale Masieri opera: si tratta di clienti benestanti: avvocati, piccoli imprenditori, professionisti spesso coetanei dell’architetto che all’architetto danno la massima fiducia. Sono persone colte e aperte al modernismo così come capaci di collezionare le opere di Afro che a New Yorck nel 1950 aveva tenuto una personale ma anche di Giuseppe Zigaina.

Cosa credi abbia lasciato Angelo Masieri come insegnamento o cosa al contrario pensi si dovrebbe imparare dal suo approccio?
Masieri è stato una breve “meteora” nel panorama dell’architettura friulana, protagonista di una particolare stagione ormai conclusa. Le sue poche opere hanno però sicuramente influenzato alcuni architetti friulani che hanno iniziato la carriera professionale negli anni cinquanta e che guardavano a maestri come Wright, Aalto e Scarpa.
Anche la fortuna critica di Masieri ha visto un percorso altalenante: troviamo l’omaggio a lui reso da autorevoli esponenti della cultura architettonica nella rivista Metron, nel 1954, quanto la definizione di ‘epigono wrightiano e scarpiano’ di molta storiografia, anche recente, che indica Masieri come semplice cooprogettista di Carlo Scarpa. Alla fine degli anni ottanta del novecento si assiste alla rivalutazione operata ad esempio da storici come Gianni Contessi, Francesco Tentori o Marco Pozzetto. Quest’ultimo vede in Masieri il capostipite di una architettura colta che traccia una “via friulana”, in particolare sul tema della casa, attraverso la rivalutazione di elementi spontanei e il recupero di materiali locali, le ampie sporgenze dei tetti, la trasmigrazione del fogolar della cucina nel più o meno grande soggiorno articolato planimetricamente secondo le necessità contingenti.


Per rispondere comunque alla tua domanda, rimando a un breve testo sulla villa Giacomuzzi a Udine in cui Arrigo Rudi scriveva di Masieri come di un architetto che ha fornito indicazioni e testimonianze circa le conquiste e il messaggio dell’architettura moderna, soprattutto ma non soltanto nell’esperienza organica (e quindi il piano libero, la continuità spaziale fra interno ed esterno). Credo che l’insegnamento che ha lasciato sia sostanzialmente questo.
Puoi dirci qualcosa sul metodo lavorativo?
Studiando i disegni di Masieri, conservati nella quasi totalità, in occasione del volume e della mostra da me curata del 1995, ho constatato il metodo di lavoro utilizzato da Angelo: dai primi veloci schizzi, talvolta balenanti già la soluzione finale, ai particolari costruttivi, ogni elemento del progetto è indagato e descritto per poter essere realizzato. Il progetto rappresenta per Masieri la ricerca personale del “formarsi dell’immagine” attraverso gli schizzi e le annotazioni grafiche.

Grazie Massimo per tutto quello che fai ed hai fatto per preservare la memoria di un vero architetto.
MB Grazie a voi. Sicuramente Angelo Masieri è stato un architetto nel senso più nobile del termine. Di Angelo mi ha però affascinato soprattutto la breve e intensa vicenda umana: il giovane bello, brillante, sportivo, benestante architetto che sposa una giovane altrettanto brillante bella e benestante. Il sogno della coppia che vorrebbe vivere a Venezia nella casa progettata dal “maestro“ Wright. La tragedia e poi la volontà della moglie Savina che commissiona a Wright la Fondazione dedicata al marito nel palazzetto sul Canal grande che avrebbe dovuto vederli felici. E ancora la battaglia di lei, perduta, per portare a compimento il progetto wrightiano. L’omaggio infine di Scarpa all’allievo, omaggio reso completando l’opera che Angelo stava realizzando (villa Romanelli) e poi progettando la tomba di lui, che non fu mai realizzata.
Così oggi le sue spoglie riposano in una tomba che non fa giustizia alle sue idee architettoniche, ma che sottolinea il carattere inaspettato e i tempi immaturi della sua morte. Una storia degna di un romanzo.


Articolo per conto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udinea pparso sul n°107 della rivista VistaCASA novembre-dicembre 2021
Fotografie: Massimo Crivellari