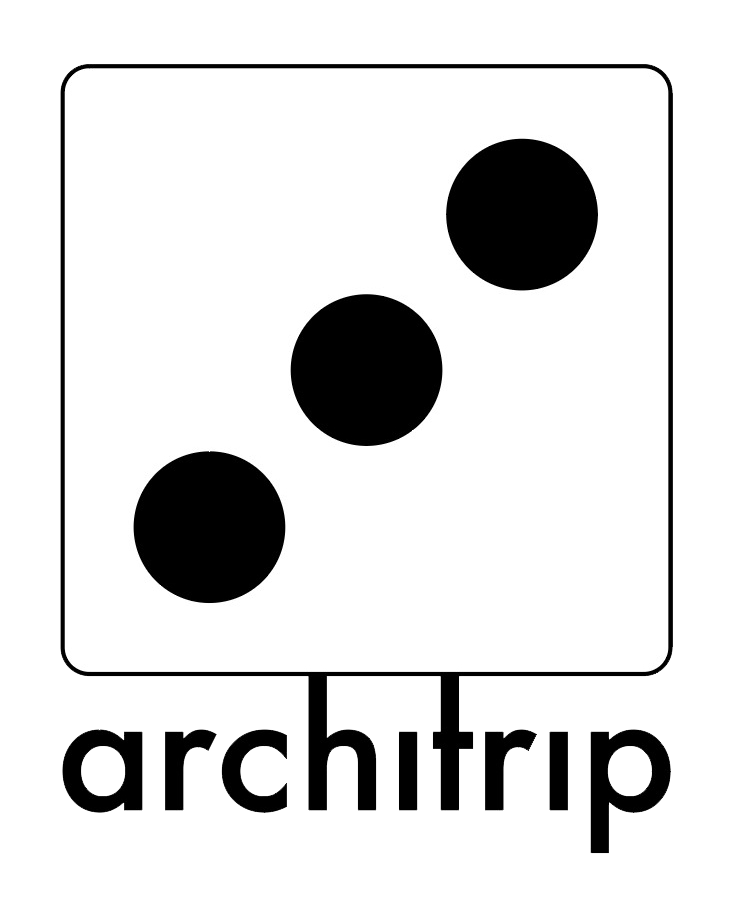Il 2025 ha visto la terza edizione de “I Martedì dell’Architettura” che quest’anno hanno fatto un deciso balzo in avanti, trovando una prestigiosa sede come la sala conferenze di Fondazione Friuli nel pieno centro della città, ma soprattutto uscendo dal contesto di Veneto, Friuli, Slovenia e Carinzia delle passate edizioni per allargare lo sguardo al Mondo.
E così la scelta è caduta davvero su studi che più diversi tra loro non potevano essere. Scelta non casuale anzi decisamente ponderata da chi ha organizzato per l’ennesima volta il tutto. Un raggruppamento collaudato in grado di coprire il più ampio ventaglio di pubblico interessato all’architettura: Federazione degli Ordini degli Architetti del Friuli Venezia Giulia, Ordine degli Architetti di Udine, associazione Mulino a Nord Est e Arte & Architettura, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Udine e noi di architrip, che un passo dopo l’altro stiamo evidentemente crescendo.
Il programma quindi? Quattro studi scelti dimensionalmente differenti allinearli dal più grande al più piccolo. Farli presentare da altri architetti locali allo scopo di comprendere come il mestiere dell’architetto si adatta ai più diversi contesti, individuare differenze e punti di contatto e comprendere soprattutto le sfide che il futuro offre allla professione.
E così una una bella sfilata di architetti presentati da altri architetti: SOM con Giovanni Vragnaz, PARK con Tommaso Michieli, Giulia De Appolonia introdotta da Alberto Sdegno e Fala atelier raccontata da Beatrice Pellos. Tutti sotto la supervisione di Aldo Peressa ideatore di questo format. Quattro martedì, quattro studi, una valanga di slide e parole.


SOM – Il gigante
SOM, ovvero Skidmore, Owings & Merrill, è uno di quegli studi che davvero ha fatto la storia dell’architettura planetaria i cui soci fondatori non sono altro che alcuni tra i più brillanti allievi di un certo Mies Van Der Rhoe. Uno di quegli studi che ti chiedi cosa ci faccia a Udine dal momento che lo skyline cittadino non super gli undici piani.
E invece no, ce lo siamo trovati davanti, con Gabriele Pascolini – friulano ma di quelli curiosi che sono andati a spasso per il pianeta – che traccia la storia dello studio planetario scorrendo terminal aeroportuali, grattacieli, masterplan collocati in ogni parte del mondo.
Tutto enorme. SOM si muove come un sistema coordinato, capace di integrare ingegneria, paesaggio, sostenibilità e ricerca formale all’interno di una struttura progettuale ramificata, capace di influenzare le trasformazioni urbane su scala globale. Difficile dire dove finisce il progetto e inizia l’infrastruttura, ma di sicuro c’è una regola.
Ed è una regola procedurale, di gestione di una macchina talmente enorme che i soci si incontrano tra loro una volta all’anno. E in un meeting fiume definiscono le linee guida dell’anno che verrà e più in generale di quell’architettura che loro realizzano assieme a pochissimi altri nel mondo.
E’ complessità coordinata fino all’ultimo dettaglio che definisce con rigore militare il congedo di ogni socio allo scopo di poter garantire costante rinnovamento allo studio e preservarlo in vita nel tempo.
E’ un processo che da tempo ha dimenticato la riconoscibilità stilistica, SOM non ha una forma ma dà forma alle necessità variabili della propria committenza, è uno studio come dicono loro “client oriented” in cui periodicamente vengono definire delle linee di stile, necessarie a mantenersi sempre sul pezzo in un mercato mutevole e spietato ma non vincolanti.
Uno studio che ha un nome che è entrato nei libri di storia dell’architettura ma che per competere nel mercato globale ha imparato a dimenticare il proprio nome. Piaccia o non piaccia Pascolini ci spiega che queste sono le regole a certi livelli.
PARK – Ricerca continua
Poi arriva PARK, studio milanese serio ma non serioso, ordinato ma non ordinario. Tocca a Tommaso Michieli fare da spalle, ma ormai è decisamente allenato. Quello che affascina di PARK è questa capacità di lavorare tra le righe, dove tutto sembra facile, ma è solo perché è fatto bene.
Riqualificano palazzi per uffici come se fosse un esercizio zen. Pulizia formale, dettagli precisi, linguaggi miscelati con intelligenza. Un’architettura che non urla ma convince. Ecco, PARK è come il tipo che si presenta al colloquio con la camicia stirata e le scarpe giuste, ma ti parla di musica elettronica degli anni ’90.
Professionisti, sì. Ma con stile. E tutto questo deriva da un importante e scientifico investimento nella ricerca. PARK ogni inizio anno analizza i megatrend legati al mondo dell’architettura e investe risorse importanti per un proprio aggiornamento interno. E così affronta temi come le neuroscienze applicate all’architettura, la progettazione del verde con scopi curativi, la progettazione di spazi flessibili piuttosto che l’impiego di materiali di origine biologica piuttosto che quel meraviglioso tema che è il concepire il costruito come una riserva, una miniera, di materiali per l’edilizia puntando ad una costante estensione del ciclo di vita dell’edilizia. Che poi loro trasformano in architettura.
Salutiamo PARK con la voglia di tornare in studio a “studiare” davvero per costruirci un arsenale di strumenti e competenze che possano fare la differenza in ogni progetto da affrontare. PARK è riuscito in quest’impresa e nel panorama nazionale rappresenta un’eccezione.

Giulia De Appolonia – La composizione rigorosa
Cambio scena. Tocca a Giulia De Appolonia, introdotta da Alberto Sdegno, e qui l’atmosfera si fa subito più raccolta. Non perché manchi la forza, anzi: i suoi progetti parlano con una voce limpida e precisa, fatta di spazi che funzionano, relazioni che si costruiscono, architetture che migliorano la vita senza farsi notare troppo.
De Appolonia è quel tipo di progettista che fa sembrare facile anche le sfide più complesse a livello di programma funzionale.
Uno studio il suo più classico, fatto da una esperta direttrice d’orchestra, colta e raffinata, che guida un piccolo team di colleghe appassionate e motivate.
La De Appollonia si muove prevalentemente nella progettazione e realizzazione edifici e spazi pubblici nella consapevolezza che, per quanto difficile nel nostro Paese, quello è un atto politico nel senso più alto del termine.
Il suo studio, in un mondo architettonico spesso confuso, decide di dare il suo contributo chiaro e cristallino dicendo a tutti noi che con passione, perseveranza e rigore si può fare!


Fala – architetti per se stessi
Chiudono il ciclo i giovani portoghesi di Fala, introdotti da Beatrice Pellos.
Fala è una creatura strana: una via di mezzo tra un atelier d’architettura e un collettivo artistico.
Le loro case sembrano disegnate da bambini molto intelligenti con la laurea. Geometrie primarie, colori pop, piastrelle come se piovesse. Ma tutto ha un senso, una logica, una coerenza che non è mai scontata. E questo nasce da una ricerca maniacale nel ventre dell’architettura ed in particolare in quelle avanguardie sperimentali degli anni ‘70 che hanno contagiato Stati Uniti e Giappone.
Ci mostrano non a caso quello che rappresenta il loro manifesto e cioè una meticolosa catalogazione di opere di architetti giapponesi decisamente di nicchia.
E poi quelle tavole grafiche – metà disegno tecnico, metà copertina di un vinile indie – che fanno venire voglia di ridisegnare tutto da capo.
Fala prende la banalità del quotidiano e la ribalta con leggerezza. Architettura che fa sorridere e pensare. Pensare soprattutto a come riescono ad operare nel mondo reale. E lì la sorpresa più inaspettata, a differenza di quello che si potrebbe immaginare i loro clienti sono persone normali che li contattato per rispondere a delle loro esigenze e loro che a differenza di SOM sono tutt’altro che “client oriented” proseguono ogni volta per la loro strada di ricerca indipendente educando con metodo e pazienza questi clienti, stupiti, nella comprensione dell’inaspettato che loro gli offrono.