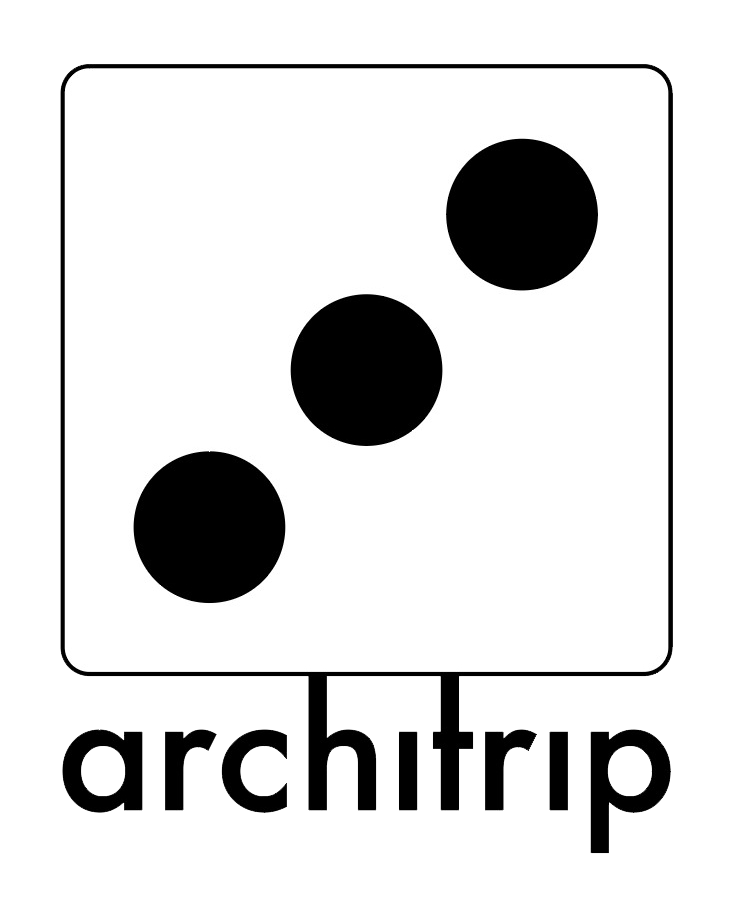Questo primo articolo dell’anno 2022 inizia con la visita a casa dell’architetto Paolo Pascolo. Quest’anno ricorre il ventennale dalla morte di un importante architetto della nostra regione Paolo Pascolo. In occasione del ricordo siamo andati a trovare i figli Sandro e Sergio, architetti anche loro, per vedere e comprendere il lavoro del padre.
Entriamo a casa dell’architetto, fatta nei primi anni ’70 del secolo scorso e subito ci accoglie una bellissima atmosfera: rilassata e calma. La luce entra dalla finestra e illumina un mobile disegnato dal padre, non nato per quella casa, ma che lo ha seguito negli anni. Pezzi iconici del design e alcuni mobili realizzati su misura ci fanno subito capire che tipo di architetto era Pascolo. La scala è leggera e diventa un filtro che mette in relazione la cucina con il salotto.
Sandro e Sergio ci fanno notare dei dettagli, come la lampada-boiserie a parete in ingresso e il grande camino che il padre ha disegnato, che è il cuore della stanza. La casa mantiene intatte le caratteristiche e la storia dell’architettura di Pascolo, ma gli accorgimenti, i materiali i disegni dei mobili ne fanno una casa contemporanea e non si direbbe che ha mezzo secolo. Una casa che arriva dopo un lungo percorso professionale. Dalla casa/ studio in via Treppo, già di Angelo Masieri, all’appartamento di piazzetta Lionello, fino ad arrivare in via Marghera in una grande villa posseduta dai Malignani e ristrutturata trasformandola in tre unità.
Uomo di grande spessore intellettuale e professionale, l’architetto Pascolo si è formato e laureato nel 1950 a Roma in quel periodo storico nel quale ebbe come maestri Bruno Zevi, Ludovico Quaroni e Saverio Muratori. Una volta tornato a Udine apre il proprio studio e la sua attività professionale viene influenzata ulteriormente dall’architettura di Frank Lloyd Writht oltre alle frequentazioni di Carlo Scarpa e Angelo Masieri. Sono gli anni del boom economico e il dibattito architettonico è intenso ed attivo. Sono gli anni in cui c’è lavoro, c’è da ricostruire un paese. Il clima è disteso e gli architetti si conoscono e si frequentano, sono amici e collaborano tra loro, Masieri,Valle, Scarpa, Marconi, Avon, Mangani, Bernardis per citarne alcuni e si confrontano anche con artisti come Celiberti, Ciussi, Ceschia.
Parallelamente lavora a stretto contatto e collabora intorno alla figura di Marcello d’Olivo. Il suo contribuito è significativo alla rinascita della città di Udine come del resto della Lignano Pineta degli anni Sessanta. Suo il progetto del Tenda Bar, dell’American Hotel e dell’Hotel delle Palme. Sono anni in cui i lavori sono davvero tanti e gli architetti non sono molti. Sergio e Sandro sono dei bambini e non hanno ancora intrapreso gli studi di architettura, ma respirano l’aria di questi anni di grande trasformazione e esordio del padre. Le frequentazioni di Paolo Pascolo non si fermano a Udine, collabora con studi romani sotto l’influenza di Zevi e questo lo porta anche a lavorare fuori regione e a fare alcune esperienze all’estero come per il quartiere residenziale a Elizabethville in Congo. É un periodo in cui la borghesia e nuovi imprenditori chiamano gli architetti per realizzare le loro ville, ne sono esempi la villa a Bressanone, (demolita) la più wrightiana dei progetti di Pascolo, la villa “padronale” di Rino Snaidero a Maniago, casa Piani a Tricesimo, e casa Boscolo in Via Andreuzzi a Udine, ma anche più tardi interventi per la collettività come l’Asilo di Santa Maria del Tempio(1970) e l’Hotel Carnia (1978) che interpreta l’architettura alpina in una dimensione organicista.

Cari Sandro e Sergio una famiglia di architetti che ritratto professionale ritagliereste per vostro padre?
Potremmo usare le parole di Vittorio Gregotti scritte in occasione del decennale della morte del papà “….. il contributo architettonico e poetico di Paolo Pascolo, si riconosce dalla cura dei dettagli, nella scelta dei materiali, nel rigore della professionalità e soprattutto nella coerente calligrafia dei bellissimi disegni e nell’interesse del tessuto spaziale che procede da un nucleo interno riconoscibile, così come dall’assenza di ogni esibizionismo estetico non necessario. È nella speranza che questi valori di identità e di precisione responsabile possano continuare ad essere protagonisti dell’architettura italiana che credo che questa occasione vada letta: specialmente dai giovani architetti.” Vittorio Gregotti, 29 gennaio 2012, in occasione del decennale dalla morte
…e ovviamente raccontateci la storia di questa casa…ci interessera capire la nascita di questo progetto.
Il progetto della casa di Via Marghera inizia alla fine degli anni ’60 quando il costruttore Tullio Gregoratti acquista la Villa e il parco di proprietà della famiglia Malignani. Il progetto affidato a Paolo Pascolo consiste nella ristrutturazione della villa trasformandola in tre unità abitative e nella realizzazione di due edifici residenziali pur mentendo verso strada una parte significativa della vegetazione del parco e lasciando una porzione di parco, seppur ridotta, ad uso delle tre abitazioni nella villa.
Il progetto di ristrutturazione crea tre abitazioni di circa 240 mq, un’abitazione unica al piano terra, e due unità duplex nei due piani superiori. L’unità esposta a sud dotata di una grande terrazza orientata a sud è diventata la casa dell’architetto e della nostra famiglia. I due appartamenti maisonette hanno accesso da un nuovo ingresso creato nel lato giardino e un vano scala che porta al primo piano. Dall’ingresso si accede direttamente nel living, aperto e spazioso che affaccia sulla terrazza veranda. Nel soggiorno il centro compositivo, come in molte case di nostro padre, è il camino in mattoni a vista dalle forme contemporanee, ma che si rifà alla tradizione del fogolâr come centro della casa e della socialità. Sullo stesso piano la grande cucina abitabile affaccia sulla terrazza. Una scala in legno leggera e trasparente lascia passare la luce tra tutti gli ambienti e collega fluidamente il piano living con la zona notte al piano superiore. Anche a questo piano gli spazi sono ampi e molto luminosi. Oltre alla camera da letto principale con il suo bagno, due altre ampie stanze sono adibite a camera da letto e studiolo. Un pannello-parete in legno scorrevole permette di creare uno spazioso open space.
In tutta la casa le porte in legno di faggio a tutta altezza creano una permeabilità visiva tra gli spazi ed aumenta la luminosità di tutti gli ambienti creando una spazialità molto moderna e attuale ancora oggi nonostante si tratti di una struttura pre-esistente di inizio secolo.L’interno è trattato come total design con una visione unificante tra spazialità e arredamento. Tutto è disegnato su misura oltre alle porte, gli scorrevoli, le boiserie, le armadiature a muro e gli spazi tecnici che risultano a scomparsa. Alcuni pezzi iconici disegnati da nostro padre, come i tavoli del soggiorno e alcuni mobili realizzati su misura per la casa-studio di Via Treppo, sono stati accuratamente modificati e adattati nella dimensione per risultare perfettamente integrati nel nuovo ambiente.
Oltre al camino come elemento di calore che avvicina e raccoglie attorno le persone uno dei luoghi della casa più amati è sempre stata la veranda. Sicuramente lo era per nostra madre, Licia, che l’ha trasformata e curata negli anni come un giardino d’inverno caratterizzato da grandi bouganville e scultoree piante di papiro.
Se per nostro padre che l’ha disegnata l’abitazione si può definire una casa-percorso, che riassume le esperienze progettuali dei primi decenni, per sua moglie Licia, è stata anche negli ultimi vent’anni dopo la scomparsa del papà, una casamondo. Un luogo completo, di interni ed esterni, accogliente, confortevole, fatto di spazi molteplici, all’interno del quale trovare nei diversi momenti della giornata, angoli sempre diversi di luce dove “andare” appositamente per stare meglio, per leggere, per disegnare, per riposare. La mamma che ha sempre coniugato l’eleganza nel vestire con quella per gli arredi, ha collaborato con il papà saltuariamente proprio per gli arredi in particolare di diversi alberghi e ha nel tempo sempre curato ogni dettaglio della casa.

Illustrateci meglio in che periodo storico ha vissuto l’architetto Pascolo, i suoi pensieri progettuali sull’abitare e come arriva alla sintesi per se…
Come accennato erano anni di grande fermento… il primo progetto di vostro padre è stato un campanile… poi invece inizia la stagione dei concorsi per complessi scolastici tra i quali quello risultato vincitore per il centro studi di Maniago e per importanti parti della città come quello per il tribunale; e poi le ville, gli edifici residenziali, scuole, alberghi, edifici industriali e ristrutturazioni.
Come ha egregiamente sintetizzato Licio Damiani nel suo articolo in occasione della scomparsa di papà, “…Erano gli anni leggendari della scoperta di Wright, Le Corbusier, Aalto, del dibattito culturale che coinvolgeva il nuovo linguaggio del costruire, vitalistico, e poetico, in stretto dialogo con l’ambiente naturale; il senso della bellezza scaturito da slancio esistenziale, anelito di libertà, fruizione “umana” dello spazio, coscienza morale…..I primi lavori rivelano l’attrazione fortemente marcata e coinvolgente che sulla nouvelle vague friulana esercitava la lezione di Wright mediata attraverso la “venezianità di Carlo Scarpa. Nell’elaborare una personale lettura della sitassi organica, Pascolo predilige l’intarsio di superfici nitide e semplificate e l’eleganza asciutta e composta dei volumi. Eleganza e signorilità, del resto, erano qualità dell’uomo, prima ancora che del professionista. Con la moglie Licia, Paolo Pascolo formava una delle coppie più ammirate nell’ambiente intellettuale udinese”

Ci interessa anche il lato umano degli architetti. Hanno caratteri forti e determinati…lo era anche vostro padre?
Nella professione senz’altro era molto determinato ma sempre con garbo e assoluta eleganza.

Che tipo di papà è stato, visto che poi avete intrapreso la sua strada?
Sergio
ricordo ancora con nitidezza quando papà parlava con grande familiarità e descriveva minuziosamente innumerevoli chiese di Roma dove lui aveva studiato. Ero assolutamente affascinato dalla sua conoscenza storica e dalla sua memoria visiva con la quale riusciva a ricostruire nel racconto o tracciando qualche veloce schizzo magari sul tovagliolo di carta del ristorante, facciate, proporzioni, capitelli e dettagli.
Questo frequentare così naturalmente e con semplicità la storia sicuramente ha contato molto nella mia successiva scelta di studiare anch’io architettura. Ovviamente poi l’architettura si respirava sempre in casa; con racconti del passato in cui sentivo parlare di Carlo Scarpa a cena da noi, o di Alvar Aalto a Firenze o del matrimonio a Milano di Piera e Gino Valle. Per me, ancora piccolo, in quel momento non erano nomi ed episodi che avevano il peso ed il significato che avrei appreso più tardi, ma i racconti e i ricordi erano di per sè sempre densi e intensi, sorprendenti sia per loro eccezionalità che per la semplicità con cui ci venivano raccontati e ci avvolgevano.
La nascita di Lignano Pineta, vissuta fina dai primi sopralluoghi sulle dune a fianco di Marcello d’Olivo, credo sia stata per me una della storie più fantastiche e cariche di avventura della mia infanzia, più di molte storie della letteratura per bambini.
Da quando ho iniziato a studiare architettura poi il respirare architettura si è fatto più intenso e diretto; io cercavo di captare dal suo lavoro e dai racconti dei cantieri e lui senza limitazione alcuna era sempre disposto ad aiutare le nostre prime fatiche progettuali qualche volta facendo le nottate in piedi come fosse uno studente come noi. Che l’architettura sia fatta di tanto impegno e necessiti passione l’ho imparato così.


…siete riusciti a lavorare insieme o inevitabilmente i rapporti erano difficili.
Sandro
Essendo entrato in studio già durante gli studi e poi definitivamente dopo la laurea, posso dire che nel lavoro i rapporti non sono stati facili, direi influenzati da parte sua dalla consapevolezza di chi sa le cose e ha molta esperienza costruttiva; per questo condividere idee e proposte che erano in qualche modo difformi dal suo modo di pensare diventava molto difficile. Tuttavia aveva una grande passione per insegnare le cose e soprattutto trasmettere la passione per il lavoro che era la sua vita.
Sergio
A parte qualche episodio durante gli studio, essendomi trasferito subito dopo la laurea a Milano per lavorare con Vittorio Gregotti, ho avuto solo molto più tardi qualche occasione per lavorare insieme e in quel caso, pur permanendo la sua superiorità di sapere costruttivo, si è creata una collaborazione più facile e armoniosa S.S. A nostra madre Licia, che ci lasciato alla fine dell’anno scorso e che ha riempito di calore umano fino all’ultimo la casa, vorremmo dedicare questo articolo del quale sarebbe stata estremamente lusingata, riconoscente e felice.


Articolo per conto dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Udine apparso sul n°108 della rivista VistaCASA gennaio-febbraio 2022
Fotografie: Elia Falaschi